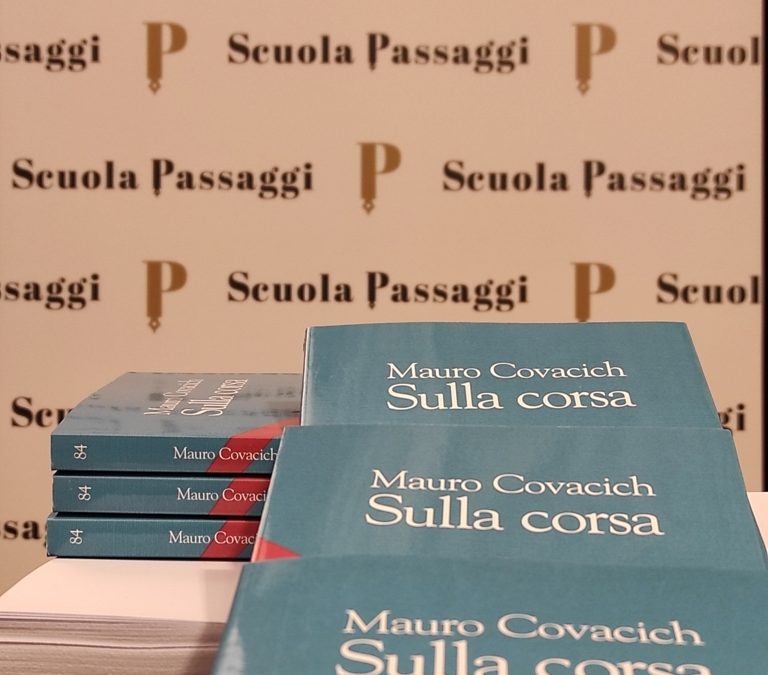La corsa è “una pratica introspettiva”, è “una prodigiosa malattia della mente”, è una “metrica interiore” che assomiglia più a un’arte marziale che a uno sport.
Quanti modi esistono per definire l’oggetto del proprio amore?
Mauro Covacich, nel suo libro Sulla corsa, edito da La Nave di Teseo, descrive con queste espressioni la passione che per oltre quarant’anni detta i tempi della sua vita, anche quella di scrittore, attraversando maratone, gare e incontri memorabili.
“Un’autobiografia letteraria” la definisce: un percorso fatto di tappe-capitoli, in cui si ricordano gli episodi che hanno caratterizzato questa lunga storia d’amore, dal colpo di fulmine all’epilogo.
“Sono primo e sto morendo”
Nel 1976 Mauro è un bambino di undici anni che, grazie a una gara di resistenza organizzata dall’azienda del padre, s’imbatte per la prima volta nella corsa e sembra intuire già in quel momento il legame che esiste fra amore e morte, fra “l’euforia e lo sgomento”, fra il godimento di profanare la strada davanti a tutti e la paura di morire a causa della fatica che fa spalancare la bocca e gli occhi, come ai mezzofondisti visti in tv, e fa diventare di piombo le cosce.
Solo da grande, quando incontrerà di nuovo la corsa e ne diventerà “un amatore”, imparerà la familiarità alla sofferenza e la capacità di controllare l’avversario che si trova dentro di sé come avviene ai maratoneti, “samurai disarmati”, in grado di trovare “una forma e una misura a un gesto letale”.
Mauro Covacich, correndo per il mondo
Mauro Covacich ci accompagna nei luoghi dei grandi eventi, i santuari di questi “asceti laici” della corsa: da New York alle Olimpiadi di Atene e Londra, da Addis Abeba di Haile Gebreselassie fino ai propri percorsi quotidiani di allenamento come il Lungotevere, l’Acqua Acetosa, passando per il paesaggio di Pordenone, ribattezzato con una nuova personale toponomastica o per il bosco di Basovizza, vicino a Trieste, dove nel ‘99 i podisti si possono confondere con i profughi provenienti dal Kosovo attraverso una Jugoslavia “ormai morta”. Covacich ci confessa di preferire correre per strada perché è un’esperienza senza pari e si ha la sensazione di “spostarsi davvero nel mondo”, ma soprattutto di amare il bordo della strada, quella zona in cui il podista è una “presenza anomala” e “destabilizzante”, il margine dove si trovano solo “rifiuti”, “animali” o viandanti alla deriva” e ci si sente liberi perché non si appartiene più a nessuna categoria, non si è pedoni, né automobilisti: si diventa fuggiaschi in balia di “un timido teppismo interiore”.
L’arte della corsa
C’è un rapporto stretto fra la corsa e la scrittura.
I Greci chiamavano piede la misura del verso in poesia.
Nel XXIII libro dell’Iliade, durante i giochi per i funerali di Patroclo, la prima gara di corsa narrata dalla letteratura occidentale non viene vinta dall’eroe più forte, né dal più giovane, ma da Odisseo, colui che possiede la metis, l’astuzia, con cui “dosa al meglio le energie”. Correre significa spesso tornare e scrivere è ingannare: azioni che l’eroe conosce e utilizza a suo favore.
Il maratoneta e lo scrittore devono possedere ritmo e resistenza per giungere al traguardo ed entrambi tentano di capire “il fuori attraverso il dentro”.
Per questo Covacich non perdona allo scrittore Haruki Murakami, quando descrive la maratona come una metafora della vita e della scrittura, di correre con gli auricolari: il maratoneta è al continuo ascolto del proprio corpo e non può essere distratto da qualcosa che finisce per essere un’interferenza nella sintonizzazione col proprio “dentro”. Meglio allora la ricostruzione di William Goldman nel suo Marathon man, da cui il film “Il Maratoneta”, in cui si corre per stare lontano “dal marcio che alligna nelle relazioni umane” o Alan Sillitoe che ne La solitudine del maratoneta individua nella corsa una componente di anarchia e ribellione. In fondo anche lo stesso Covacich con la sua scrittura asciutta, ma sempre molto evocativa, ci svela che “chi corre è in guerra e vorrebbe tanto essere in pace”.